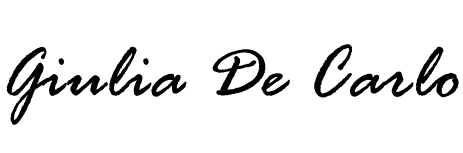Cos’è la PREPSICOSI? E perchè nel passato nacque l’esigenza di approfondire questa diagnosi?
Spesso si sente parlare di prepsicosi, ma la letteratura scientifica italiana in merito è abbastanza povera, anche perchè è un termine che è stato utilizzato prevalentemente dalla scuola psicoanalitica francese per differenziare una tipologia particolare di pazienti, che per le loro caratteristiche caratteriali, in un primo momento venivano classificati come nevrotici, per poi invece deludere le aspettative dei terapeuti relative alle loro capacità elaborative. Con questi pazienti, i terapeuti dopo una serie di scambi comunicativi apparentemente buoni, spesso si trovavano confrontati con l’inconsistenza delle loro elaborazioni. Di conseguenza più che elaborativi, queste persone, apparivano, piuttosto, essere accorpativi del pensiero dell’altro, e accondiscendenti su tutto ciò che gli veniva detto, senza mostrare un pensiero proprio. Questo stato di cose portò diversi autori, a voler approfondire queste personalità al fine di non incorrere nel rischio di trattare questi pazienti come nevrotici, e dunque, di applicare metodiche psicoterapeutiche non solo non adatte, ma alle volte controproducenti la salute del pazienti.

Oggi per prepsicosi si intende una tipica modalità di organizzazione della personalità. Diversi autori (Petrini, De Carlo, 2013) sostengono che con questo termine non viene inteso un vero e proprio disturbo, ma una organizzazione profonda di percepire se stessi e l’altro (l’oggetto interno) e dunque di interagire in seguito a quei introietti.
In questo senso la prepsicosi rappresenta uno stile esclusivo di rapportare l’io all’altro (l’oggetto) nelle relazione che tra origine dallo sviluppo delle prime fasi nell’infanzia.
In particolare gli autori della scuola psicoanalitica francese (Katan, M.,1953) sostengono che la prepsicosi è un organizzazione della personalità che si formerebbe in seguito ad un arresto evolutivo intorno al secondo sotto-stadio anale del trattenere. Per questo motivo l’angoscia del prepsicotico di fronte alle difficoltà rientrerebbe nel registro della psicosi, e dunque, secondo un angoscia di frammentazione. Tuttavia queste personalità mostrerebbero di aver vissuto un attaccamento fusionale con il car-giver non del tutto tossico su cui, sembrerebbe che abbiano imparato ad appoggiarsi per mantenere un’integrità psicofisica. L’angoscia pertanto di frammentazione sarebbe di tipo relazionale ossia un’angoscia di frammentazione da perdita dell’oggetto interno.
E’ grazie prevalentemente agli studi della scuola francese psicoanalitica che è stato possibile approfondire questa tematica, che nella fattispecie si tratterebbe di organizzazioni di personalità che nell’apparenza mostrano un repertorio di comportamenti adeguati alle circostanze, ma che poi dopo le prime interazioni, lasciano il terapeuta deluso a causa di alcune anomalie del loro modo di relazionarsi. E’ frequente che alcuni terapeuti in un primo momento facciano diagnosi di nevrosi, cominciando un trattamento per questo tipo di disturbo ma a differenza delle organizzazioni nevrotiche queste personalità mostrano di non possedere capacità elaborative. Ta una seduta e l’altra, ben presto, il terapeuta noterà che non si stabilisce nessun insight nel paziente, e che questo si è piuttosto aggrappato alle parole che ai loro significati. Si tratterebbe di persone che prendono a prestito il pensiero dell’altro assumendolo come proprio, ma senza comprenderne il senso e dunque senza apportare cambiamenti nel loro modo di vedere quegli aspetti della vita che li hanno portati in terapia. L’aggrappamente all’altro è la difesa che loro attuano per non scivolare nel vuoto ano-oggettuale, in altre parole per mantere l’altro a portata di mano e sentirsi in una relazione. Per queste persone la mancanza nella loro vita di colui verso cui si sono relazionati li confronta con un vuoto relazionale che vivono con l’angoscia di disgregarsi. Questa modalità difeva dall’angoscia di frammentazione si realizza in un aggrappamento al pensiero del terapeuta che finisce per atribuire abilità elaborative a queste persone che non posseggono. Infatti se non si analizza il controtransfert e non si notano le anomalie di comportamento nel momento in cui si fa una diagnosi seguendo solo gli aspetti sintomatologici è facile sbagliare e non collacarli su livelli bassi del funzionamento mentale.
Infatti secondo il DSM-5, o l’ICD 11, che distingue i disturbi secondo le manifestazioni sintomatologiche (criteri nosologici), queste le perosnalità prepsicotiche quando entrano in crisi e manifestano disagio psichico rientrerebbero nei disturbi di personalità schizoide, dipendente e alcuni disordini paranoici, ciclotimici, la personalità ipomaniacale ecc., o altri tipi di disturbi dell’umore collocabili di solito a livelli apparentemente nevrotici ma che non contemplano l’angoscia di castrazione.
La modalità relazionale che queste organizzazioni di personalità attuano con l’altro imitano quell’investimento tipico delle organizzazioni nevrotiche, buttando funo negli occhi al perapeuta che potrebbe illudersi che possa trattarsi di un’organizzazione nevrotica. Questo a lungo andare comporta un grande problema nel trattamento perché, infatti questi individui trattati come nevrotici possono incorrere a rischi, che nel migliore dei casi non comporterà nessun miglioramento del loro stato, ma nel peggiore dei casi, può risolversi in uno scompenso di quel vacillante equilibrio su cui si poggia il loro equilibrio psichico.
Gli studi che hanno portato nel panorama francese alla diffusione di una diagnosi di personalità prepsicotica risalgono ai trattati di Katan M. (1953) e l’analisi che fece del caso Schreber presente nella rivista J. Psicho-Ana n° 34 articolo intitolato “Schreber’s prepsychotic phase”, pag 43- 51. In questo articolo Katan analizza il periodo che precede lo scompenso psicotico del famoso caso Scherber. Questo suo elaborato apre una prospettiviva interessante in quel periodo ossia la possibilità di curare preventivamente i pazienti a rischio di scompenso. L ‘ossservazione dunque di molti autori, specialmete nello scenario psicoanalitico, si rivolge a quei soggetti con sintomi di alterazione del pensiero e angoscia di frammentazione ma che allo stato presente non mostravano condizioni morbose importanti (deliri, allucinazioni o stati di scissione dell’io). Per molti clinici questi soggetti erano semplicemente soggetti psicotici che presentavano i sintomi che precedevano lo scompenso, o addiruttura schizofrenici nella fase negativa prima dell’esordio della malattia. Partendo dagli studi di KATAN alcuni autori come Bergeret, Lacan, Gillièron, Petrini, Mandese hanno approfondito lo stato psichico di molti pazienti, non troppo malati per rientrare nella categoria della psicosi, ma nemmeno con un livello mentale adeguato per rientrare in altre categorie in quanto il loro livello di fare analisi della realtà si presentava compromesso. Questi dati clinici hanno confrontato i terapeuti con una serie di pazienti sulla soglia della psicosi ma che per le loro modalità relazionali e difensive difficilmente di scompensavano. E’ stato osservato che lo scenario sintomatologico di questi pazienti è molto variegato, si presentano spesso soggetti con sintomi molto debilitanti, e altri soggetti abbastanza adatttati alla realtà ma con lacune nell’analisi del pensiero.
Questi tipo di pazienti però non erano estranei nello scenario clinino del 900 perchè erano stati già descritti da altri autori per le loro particolarità. Infatti due autori in particolar modo si erano confrontati con queste tipologie di pazienti: Donald Winnicot definendole Personalità “Falso sé”, e Helene Deutsch e la personalità “COME SE”. Mentre J. Bergeret spesso ha parlato nei suoi testi dei periodi PRE-PSICOTICI riferendosi all’eziopatogenesi dell’ organizzazione psicotica durante l’infanzia. In ogni caso possiamo ritrovare nel suo concetto di “normalità patologica” presente nel testo del 1964 “Personalità normale e patologica”dei riferimenti alle personalità “Come se” di Helene Deutsch e delle “Falso sé” di Winnicott. Qui di sotto i link per approfondire anche questi argomenti:
https://www.giuliadecarlo.it/helene-deutsch-e-la-personalita-come-se/
https://www.giuliadecarlo.it/crisi-e-trattamento-di-un-paziente-con-diagnosi-di-falso-se/
Bibliografia
Petrini P. , Giuia. I. De Carlo (2013). Psiche e Cambiamento. Miti, percorsi e processi della relazione psicoterapeutica. FrancoAngeli
Katan M. (1953) Schreber’s prepsychotic phase, in J. Psicho-Anal., 34, 43- 51.
Grazie dell’attenzione
Psicologa, Psicoterapeuta psicoanalitico
Dott.ssa Giulia De Carlo
Studio privato: Corso Gramsci, 133 Palagianello (Ta) Tel 3201987812
Email: giuliadecarlo@hotmail.com