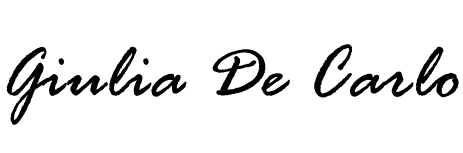Tutta la VITA ONIRICA individuale “nella sua totalità” segue un suo FINE e un proprio SCOPO. Questa è la spiegazione della psicoanalista junghiana Marie Von Franz dopo aver analizzato per tanti anni i sogni di molti pazienti. È frequente domandarsi:
Tutta la VITA ONIRICA individuale “nella sua totalità” segue un suo FINE e un proprio SCOPO. Questa è la spiegazione della psicoanalista junghiana Marie Von Franz dopo aver analizzato per tanti anni i sogni di molti pazienti. È frequente domandarsi:
– “Come mai sogno spesso la stessa cosa? E che significato hanno i miei sogni ricorrenti!?”
In generale gli esperti hanno constatato che cadere, essere inseguiti, essere aggrediti o feriti, provare e riprovare a fare qualcosa, sostenere esami, perdere i denti, ritrovarsi in pubblico senza abiti o senza scarpe, arrivare tardi, perdersi, essere rinchiusi, assistere a catastrofi naturali sono alcuni dei sogni più frequenti, ma naturalmente c’è ne sono tanti altri. La maggior parte dei sogni ricorrenti ha un carattere affettivo negativo, essendo associati a situazioni di pericolo, paura, panico, imbarazzo, rabbia, vergogna, colpa, impotenza, tristezza. Meno frequentemente, riguardano contenuti piacevoli come mangiare, fare sesso, volare. Si stima che il 70 per cento delle persone hanno sogni ricorrenti, questi sogni possono ripetersi periodicamente ogni settimana, ogni mese e di solito rappresentano questioni che ci riguardano da vicino o che ci stanno a cuore. È da sottolineare che di solito le tematiche interiori, per noi delicate vengono sognate un po’ mascherate, per non turbare troppo il sognatore, perciò è possibile che per comprendere il significato di un sogno è necessario interpretarlo. Freud nel famoso testo dell'”interpretazione dei sogni” spiega che a operare questo mascheramento è la censura, ossia un meccanismo di difesa. Pertanto comprendere i messaggi che i sogni ci portano non è sempre semplice perché alle volte riguardano aspetti esistenziali legati a ferite emotive. Infatti è proprio per questo che la mente durante la notte trasforma dei contenuti in immagini sopportabili. È importante mettere in evidenza però un aspetto fondamentale in quanto non tutti sanno che il sogno in sé ha anche una funzione curativa. Detta in parole povere mentre sogniamo la nostra mente lavora in maniera autonoma cercando di risolvere problematiche che ci recano tensione e che influenzano il nostro quotidiano. Questa trasformazione naturale che si innesca quando dormiamo esiste per un motivo molto importante in quanto il sogno ha la funzione di aiutarci nella nostra esistenza. Riferisce Marie Von Franz, stretta collaboratrice di Jung, che lui interpretò addirittura 80000 sogni. Dalle sue lunghe analisi Jung concluse che i sogni di un individuo sono collegati li uni con gli altri, anche se per comprendere quale sia il legame che li unisce è necessario analizzare un buon numero dei propri sogni e per un tempo abbastanza lungo. Riflettendo su di noi facendo mente locale dei nostri sogni è facile vedere che, a prima acchito, questi sono tutti diversi, anche quelli ricorrenti appaiono, ogni volta, con delle varianti. A prima vista sembra che tutti i sogni siano assestanti eppure in realtà ci sono delle strette relazioni. Questi collegamenti non sono subito evidenti ma con il tempo è possibile rilevarli, per esempio dopo un buon periodo di analisi personale. In questi casi si vede che durante un percorso cominciamo a mettere a fuoco dei nodi problematici di noi e contemporaneamente prendiamo coscienza del motivo per cui abbiamo fatto quell’uno o quell’altro sogno. Marie Von Franz psicanalista e collega di C.G. Jung ha partecipato alla stesura del testo “l’uomo e i suoi simboli” e scopriamo nel testo la sua posizione circa il significato e la funzione del sogno. Nel testo afferma che la VITA ONIRICA INDIVIDUALE “NELLA SUA TOTALITÀ” segue un suo FINE, e un suo SCOPO in quanto nei sogni si possono individuare una logica soggiacente che spinge l’individuo verso l’elaborazione del suo mondo interiore. Di riflesso questo processo naturale mette in luce che la “pulsione di individuazione” possiede delle sue trame e direzioni che si possono intravedere nell’intercedere dei sogni. Ma leggiamo le parole che Marie scrive riflettendo sul fine ultimo dei sogni nella sua totalità:
“Jung si interroga su questa dimensione psichica. All’epoca Freud affermava che il sogno esisteva per soddisfare un desiderio rimosso. Questa idea a Jung gli sembrava molto riduttiva, in quanto lui ci vedeva molto di più che la realizzazione immaginaria di un desiderio che non era possibile realizzare da svegli.”[…] ”Una volta che si sia compresa l’importanza (cioè, la forza d’urto, costruttiva o distruttiva) dei simboli creati dall’inconscio, resta da risolvere il difficile problema della loro interpretazione. Il dottor Jung ha dimostrato che la soluzione del problema dipende dalla circostanza che ogni particolare interpretazione «scatti», abbia un significato, nei confronti dell’individuo interessato. In tal modo ha indicato quali possano essere significato e funzione del simbolo onirico. Ma, nel corso dello sviluppo della teoria di Jung, questa possibilità ha dato origine a un altro problema: qual è il fine della vita onirica individuale “nella sua totalità”? Quale ruolo dispiegano i sogni, non solo nella economia psichica immediata, ma nella vita complessiva dell’uomo?Sottoponendo a osservazione una grande quantità di soggetti, e studiandone i sogni (riteneva di avere interpretato almeno 80000 sogni), Jung scoprì non solo che tutti i sogni sono, in varia misura, rilevanti per la vita del soggetto, ma che essi si inseriscono in una trama complessa di fattori psicologici. E scoprì anche che, nella loro globalità, i sogni si presentano secondo un certo schema. Jung chiamò tale schema «il processo di individuazione». Dal momento che i sogni creano immagini e situazioni nuove notte per notte, chi non sia un buon osservatore non potrà essere in grado di individuare la loro struttura schematica generale. Ma, se si studiano e si controllano i propri sogni durante un periodo di qualche anno, e se ne esamina la successione, si vedrà che, nel corso di questa, certi contenuti emergono, si dissolvono e si presentano di nuovo. Molti sognano spesso le stesse figure o situazioni, gli stessi paesaggi; tuttavia, se ci si desse la briga di seguire la serie di tali immagini, ci si renderebbe conto che esse mutano, lentamente ma percettibilmente. Questi mutamenti possono accelerare il loro ritmo, se l’atteggiamento del soggetto sognante è influenzato da opportune interpretazioni dei sogni e dei loro contenuti simbolici. Così, la nostra attività onirica crea e segue uno schema tortuoso nel quale, di volta in volta, le tendenze e i motivi individuali si manifestano, scompaiono e si presentano nuovamente. Esaminando, nel corso di un lungo periodo di tempo, questo disegno obliquo, sarà possibile individuare l’opera di una recondita tendenza direzionale o regolatrice, che determina un lento, impercettibile processo di sviluppo psichico – il processo di individuazione.”
Alcune precisazioni sulla natura dei sogni ricorrenti
In psicologia (e in particolare nell’ottica psicoanalitica) un’ipotesi esplicativa dei sogni ricorrenti è che mettano in luce qualcosa per cui siamo preoccupati o che dobbiamo prendere in considerazione, tematiche importanti come decisioni da prendere, cambiamenti da affrontare, perdite o minacce di perdite, conflitti, insoddisfazione. Possono riferirsi a problematiche del momento, oppure a temi che accompagnano tutta la vita della persona e periodicamente si ripresentano. Si ritiene che i sogni ricorrenti riflettano in generale un’alta attivazione emotiva o una condizione di stress emotivo. Sono associati a periodi di minor benessere psicologico e alla presenza di ansia e umore depresso durante la veglia e sono fortemente correlati con eventi e situazioni vissute durante la giornata; si ipotizza che mettano in luce anche gli aspetti di cui siamo meno consapevoli o che tentiamo di nascondere pure a noi stessi. Un’ipotesi supportata da diversi autori sulla funzione dei sogni ricorrenti è che questo tipo di sogno da una parte segnali l’esigenza di affrontare un problema, dall’altra sia esso stesso un tentativo di trovare soluzione al problema, attraverso ciò che accade nel sogno. Ma a ben guardare i clinici sottolineano che non esiste un’interpretazione univoca del contenuto dei sogni, perché il possibile significato dipende da tanti fattori estremamente soggettivi, cosicché lo stesso identico sogno può avere significato psicologico completamente diverso da una persona all’altra, in base alle associazioni che suscita nella mente di ciascuno. In generale, però, i sogni e in particolare i sogni ricorrenti, possono offrirci lo spunto per riflettere su di noi, su aspettative e paure; possono aiutarci a comprendere i motivi dei nostri comportamenti; possono far emergere aspetti di noi finora rimasti in ombra e aiutarci ad analizzarli per elaborare quelle situazioni sospese e inrisolte che attendono di essere affrontate.
Approfondisci leggendo gli articoli sullo stesso argomento:
https://www.giuliadecarlo.it/e-possibile-attraverso-i-sogni-risolvere-situazioni-difficili/
Bibliografia
- Aite P., Paesaggi della psiche. Il gioco della sabbia nell’analisi junghiana, Boringhieri, 2002
- André J. (2008). L’après-coup nella teoria e nella clinica. Psicoterapia e Scienze Umane, XLII, 4: 471-498.
- De Luca Comandini F., Immaginazione attiva, in Trattato di Psicologia Analitica, Utet, Torino, 1992
- Freud S. L’interpretazione dei sogni.
- Hannah B., Some remarks on active Imagination, Spring, New York, 1953
- Hannah, B. Encounters with the Soul: Active Imagination as Developed by C.G. Jung. Santa Monica: Sigo, 1981.
- Jung, C. G. Il Libro Rosso[1913 – 1930], Bollati Boringhieri, 2010
- Jung, C. G. [1916], La struttura dell’inconscio, in Opere, vol. VII. Torino, Boringhieri, 1983
- Jung, C. G. [1921], Tipi psicologici, in Opere, vol. VI. Torino, Boringhieri, 1969
- Jung, C. G. [1957/58], La funzione trascendente, in Opere, vol. VIII. Torino, Boringhieri, 1976
- Jung, C. G. [1960-1969], The visions seminars, vol. 1 e 2, Zurich, Spring publications, 1976
- Jung, C. G. [1961], Ricordi, sogni, riflessioni(a cura di A. Jaffè), Milano, Rizzoli, 1978
- Jung, Carl. Jung su Active Imagination(1997) Princeton U.
- F. C. Hull, bibliografia di tutti i testi junghiani sull’immaginazione attiva, Spring, 1971, p. 115
- Kroke A., L’uso dell’immaginazione attiva nella seduta analitica: alcuni aspetti terapeutici, in Studi junghiani, vol. 10, n.2, 2004.
- Johnson, Robert A. Inner Work(1986) Harper & Row
- Migone P. (1994). The problem of “real” trauma and the future of psychoanalysis. International Forum of Psychoanalysis, III, 2: 89-96.
- Miranda, Punita (2013) L’immaginazione attiva di CG Jung: personalità alternative e stati di coscienza alterati,Jaarboek CG Jung Vereniging Nederland. Nr. 29 (2013), 36-58.
- Rosati O., L’attivazione dell’immagine nello psicoplay junghianoin Trattato di psicologia analitica a cura di A. Carotenuto, Utet, 1992.
- Tibaldi M., Pratica dell’immaginazione attiva, La lepre edizioni, 2011.
- Thomä H. & Cheshire N. (1991). Freud’s Nachträglichkein and Strachey’s “deferred action”: trauma, constructions and the direction of causality. Int. Rev. Psycho-Anal., 18: 407-427.
- Thomä H. & Kächele H. (1988). Lehrbuch der psychoanalytischen Therapie. 2: Praxis. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag (trad. it.: Trattato di terapia psicoanalitica. 2: Pratica clinica. Torino: Bollati Boringhieri, 1993; Trad. inglese: Psychoanaytic Practice. Vol. 2: Clinical Studies. Berlin: Springer Verlag, 1992)
- Von Franz M-L., Il processo di individuazione, in L’uomo e i suoi simboli, Tea, Milano, 1964
- Von Franz M-L., L’immaginazione attiva, in Rivista di psicologia analitica, nr. 17, 1978 https://www.massimilianocau.it/wp-content/uploads/2018/11/immaginazione-attiva-von-franz.pdf