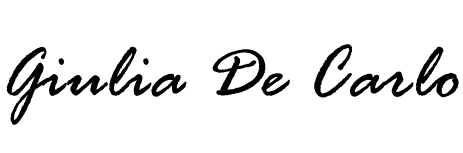La SPERANZA alle volte è l’unica cosa che ci spinge a reagire verso situazioni difficili, riuscendo a trovare soluzioni nuove e iniziare un processo di cambiamento. Il MITO del Vaso di PANDORA permette di comprendere il valore della SPERANZA nelle situazioni critiche.
La SPERANZA alle volte è l’unica cosa che ci spinge a reagire verso situazioni difficili, riuscendo a trovare soluzioni nuove e iniziare un processo di cambiamento. Il MITO del Vaso di PANDORA permette di comprendere il valore della SPERANZA nelle situazioni critiche.
Il mito del vaso di Pandora
Secondo il mito greco del vaso di Pandora, Zeus, temendo che l’umanità stesse diventando troppo potente minacciando il dominio degli dèi, ideò uno stratagemma per indebolirla. Come dono di nozze, regalò a Pandora ( futura moglie di Epimeteo, fratello di Prometeo) un vaso che le era stato espressamente vietato di aprire. Al suo interno erano stati racchiusi tutti i mali del mondo: la malattia, la sofferenza, la morte. Tuttavia, Pandora, spinta dalla curiosità, non riuscì a resistere alla tentazione e, in un momento di debolezza, sollevò il coperchio del vaso. In quell’istante, tutti i mali si sparsero nel mondo, colpendo inesorabilmente l’umanità. Resasi conto dell’errore, Pandora tentò disperatamente di richiudere il vaso, ma nel farlo intrappolò al suo interno l’unica cosa che ancora non si era liberata: la Speranza. A seguito di questo evento, gli uomini caddero in uno stato di disperazione, sopraffatti dalle sciagure che ora li affliggevano. Solo quando la Speranza fu finalmente liberata, l’umanità riuscì a risollevarsi, trovando la forza di affrontare la propria condizione di mortalità e sofferenza. Il mito insegna che il dolore e le difficoltà della vita possono essere sopportati solo se si conserva un barlume di speranza nel cambiamento. Senza di essa, l’uomo sarebbe destinato a soccombere alla disperazione. Nei momento di dolore, “crisi” e sofferenza alle volte la speranza è l’unica ancora a cui ci si può aggrappare per poter andare avanti. Grazie ad essa si può avere fiducia che le cose miglioreranno. Questo aspetto è evidenziato anche dall’ origine della parola crisi. Infatti se prendiamo l’etimologia della parola vediamo come questa significa separazione, decisione, prova. Questo mette in evidenza che ogni crisi porta con sé due facce della stessa medaglia:
⚡ Da un lato, il tormento e la rottura di qualcosa che non funziona più.
🌿 Dall’altro, la possibilità di trasformazione e rinascita.
Dunque le crisi possono rappresentare quei momenti di svolta che da cui partire migliorare. Ma vivere questi massaggi tormentati con fiducia non è facile, perché in quello stato viene visto tutto sotto la lente dello sconforto.
La Crisi rappresenta un Ponte che unisce le Difficoltà con le possibilità di Trasformazione
Già a partire l’etimologia e il significato della parola crisi vediamo come essa evochi spesso un senso di incertezza, instabilità e sofferenza, infatti in greco, krisis significa separazione, decisione, prova, giudizio e vuole indicare quel punto di massima espressione di una caratteristica da cui poi si dipana un altro aspetto divergente (Chanlat, 1990). Seguendo questa direzione vediamo che la parola crisi significava in greco anche “crine” e indicava il momento in cui la vetta della montagna discende dopo il suo risalire. Questo modo di rappresentare le fasi della crisi la legarono per analogia a tutto ciò che si manifestava con un apice tra due estremi. Quel momento in senso esistenziale è quell’elemento di trasformazione, spingendo a scegliere una nuova direzione. Questo suggerisce che, pur essendo dolorosa, ogni crisi porta con sé il seme della crescita, ma se non superata può condurre alla stagnazione, al malessere e anche alla psicopatologia. Più si cerca di ignorare o reprimere i momenti di crisi, più essi si manifestano attraverso tensioni emotive e fisiche, fino a diventare insostenibili. La crisi è una costante della vita umana. Cambiamenti improvvisi, sfide inattese e rotture possono disorientare, ma è nel confronto con il diverso che è possibile trovare le risorse per una rigenerazione; purtroppo affrontare una crisi non è semplice, il cambiamento è spesso doloroso.
Gli studi sui processi di crisi in psicologia
Nella vita di ogni individuo, i momenti di crisi psicologica rappresentano passaggi di cruciali. In quanto rotture di equilibri preesistenti, essi si configurano come esperienze dolorose ma potenzialmente trasformative. La crisi, quindi, non è semplicemente uno stato di disordine, ma un’opportunità per discernere. Spesso, è la speranza a sostenere la possibilità di un cambiamento. Senza di essa, il dolore rischia di trasformarsi in disperazione. Il mito del vaso di Pandora offre una visione emblematica del ruolo della fiducia verso il futuro nei momenti di sconforto. Secondo Esiodo (Le opere e i giorni, VIII sec. A.C.), quando Pandora aprì il vaso donatole da Zeus, tutti i mali si sparsero nel mondo. Solo la speranza (elpis), rimasta inizialmente imprigionata, fu successivamente liberata, restituendo all’umanità la forza per affrontare la sofferenza. Questo mito, come sottolinea Hillman (2008), evidenzia che senza speranza non può esserci trasformazione, ma solo stagnazione. In ambito psicologico, autori come Carl Gustav Jung hanno posto la crisi al centro del processo di individuazione. Per Jung, ogni fase di rottura può essere letta come un momento di confronto con l’Ombra, una discesa necessaria per integrare contenuti psichici inconsci e accedere a un livello superiore di consapevolezza (Jung, 1961). La crisi diventa dunque un simbolo di passaggio: dalla frattura all’integrazione, dal caos a una nuova armonia interna. Anche la psicologia evolutiva e sistemica evidenzia come le fasi di discontinuità siano indispensabili allo sviluppo. Secondo Watzlawick (1976), solo un cambiamento di secondo ordine – ovvero una trasformazione strutturale del sistema – può generare un reale rinnovamento. Questo tipo di cambiamento spesso si verifica proprio in seguito a un momento critico, quando le soluzioni precedenti non sono più funzionali. Interessante è inoltre notare come, nella lingua cinese, la parola “crisi” (wei ji) è composta da due caratteri: wei (pericolo) e ji (opportunità). Sebbene la traduzione non sia perfettamente sovrapponibile alle interpretazioni occidentali, essa suggerisce comunque un’idea fondamentale: ogni crisi contiene in sé la possibilità di un cambiamento positivo (Capra & Luisi, 2014). Dunque, possiamo leggere la crisi come un processo dialettico, dove da un lato ci sono la perdita di punti di riferimento e la destabilizzazione dell’identità, e dall’altro l’apertura a nuove possibilità, la messa in discussione di schemi obsoleti, la costruzione di significati inediti. Spesso, però, questo potenziale trasformativo non è immediatamente visibile. Secondo Viktor Frankl (2005), sopravvissuto ai campi di concentramento e fondatore della logoterapia, «chi ha un perché per vivere, può sopportare quasi ogni come». La crisi, dunque, può essere considerata una soglia esistenziale. È il momento in cui siamo chiamati a scegliere: restare nella confusione o intraprendere un cammino di consapevolezza. Uno degli aspetti più complessi della crisi è comprendere cosa è necessario cambiare e cosa, invece, va mantenuto e valorizzato. A volte, proprio ciò che ci ha ferito in passato può insegnarci a costruire il nostro futuro in modo più solido. Per affrontarla in modo costruttivo, è spesso necessario un supporto esterno – un terapeuta, un mentore, o semplicemente un testimone empatico – che ci aiuti a distinguere ciò che va lasciato andare da ciò che va valorizzato. Come afferma Edgar Morin (2001), «la complessità dell’esistenza implica che la vita sia attraversata da crisi ricorrenti», ma è proprio in esse che si radica la possibilità di rigenerazione.
Conclusione
Le crisi non sono eventi accidentali, ma parte integrante del nostro sviluppo psicologico e spirituale. Accoglierle significa riconoscerne la funzione trasformativa e abbandonare la tentazione di evitarle o reprimerle. In questo percorso, la speranza agisce come forza rigenerativa che ci permette di ricostruire, di ridefinirci, e di dare nuovo senso alla nostra esistenza. Con il giusto accompagnamento e una visione consapevole, ogni crisi può diventare l’inizio di qualcosa di nuovo.
Riferimenti bibliografici
Capra, F., & Luisi, P. L. (2014). Vita e natura. Una visione sistemica. Milano: Aboca Edizioni.
Chanlat, J.-F. (1990). L’individu dans l’organisation. Paris: Eska.
Esiodo. (VIII sec. A.C.). Le opere e i giorni.
Frankl, V. E. (2005). Uno psicologo nei lager. Milano: FrancoAngeli.
Hillman, J. (2008). Il mito dell’analisi. Milano: Adelphi.
Jung, C. G. (1961). Ricordi, sogni, riflessioni. Milano: BUR.
Morin, E. (2001). La testa ben fatta. Milano: Raffaello Cortina.
Watzlawick, P., Weakland, J. H., & Fisch, R. (1976). Change. Sulla formazione e la soluzione dei problemi. Milano: Astrolabio.